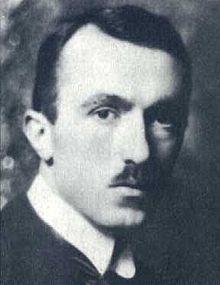- dall’archivio di repubblica 2006
Un eroe sconfitto che abitava lontano dalla realtà
Ho conosciuto Carlo Emilio Gadda alla fine del 1955, o nei primi mesi del 1956, quando non avevo ancora ventisei anni. Lui ne aveva sessantadue. Diventammo subito amici. Non era affatto timido, come dice la leggenda: o lo era coi prepotenti, coi Grandi, coi noiosi, coi seccatori, coi facitori di frasi fatte; non con le persone che provavano simpatia ed affetto per lui. Aveva per gli amici un’ infinita gentilezza e tenerezza: ogni specie di attenzioni: non solo quelle borghesi – il miglior posto a tavola, il mazzo di fiori, la scatola di marrons glacés -, ma la vera tenerezza del cuore, che si indovinava da un sorriso o da un aggettivo. Mentre stavamo seduti ad un caffè di piazza del Popolo, lui non era il più grande prosatore italiano del secolo, né io un giovane critico sconosciutissimo, che insegnava negli Avviamenti Professionali. Con lui non c’ era mai nessun rapporto di superiorità o di inferiorità: non aveva mai un’ ombra di supponenza o di alterigia. Eravamo soltanto due esseri umani, che discorrevamo delle cose che tenevamo a cuore. Avrei potuto restare sempre lì a parlare con lui, mentre le persone entravano e uscivano dal caffè, attraversavano piazza del Popolo, o salivano verso il Pincio, come ai tempi di Goethe e di Leopardi. Mi piaceva moltissimo ascoltarlo. Parlava con quella nobile semplicità, quella sovrana chiarezza, quella complessa sobrietà, quella elegante sprezzatura (diceva Castiglione), con cui parlavano Manzoni e Leopardi, obbedendo alla tradizione italiana. Non era mai difficile o pomposo: non ricercava acutezze; solo, talvolta, qualche parola di origine scientifica o qualche metafora. Il ritmo delle frasi era lento, grave e posato: senza gli improvvisi di velocità e di spirito, che distinguono la conversazione inglese e francese. A volte, le sue parole sembravano venire da lontano, molto lontano, come se avessero percorso una strada faticosa e dolorosa, che egli solo conosceva. Non comprendeva il linguaggio complicato. Quando invitava a cena Gianfranco Contini (per il quale aveva moltissimo affetto), o ascoltava una sua conferenza, mi faceva sedere accanto a sé. Contini parlava in continiano: una lingua personale, composta in buona parte di gaddiano. «La prego, mi diceva: se non capisco, mi spieghi». Così, all’ inizio del 1956, nacque tra noi una specie di sodalizio, che durò almeno dieci anni. Non ero il solo a subire il suo fascino: c’ era sempre qualcuno, un giovane letterato, o una portiera, o una cameriera, o un avvocato, o una collaboratrice della televisione, che decideva di dedicargli la propria vita. Quanto a me, provavo per lui un’ immensa venerazione, come non ho mai provato per nessuno. Non veneravo soltanto il Pasticciaccio o La cognizione del dolore: ma tutto ciò che egli faceva o diceva o pensava o immaginava o fantasticava. Non mi importava affatto che qualcuno dicesse che Gadda era un nevrotico, o un ipocondriaco, o un paranoico. Per me, anche le sue minime fantasie emanavano da una grande figura dolorosa, che restava nell’ ombra. Una o due volte la settimana, andavo a via Blumenstihl 19 – «sulla catena di Monte Mario, a centotrenta metri sul mare e a ottanta sul fiume, presso il manicomio Nostra Signora della Pietà, che confido avrà pietà anche di me». Superavo la sorridente sorveglianza della portiera russa, Katja, e della «fedele Giuseppina», che sapevano distinguere tra i visitatori. Parlavamo per ore: i suoi vecchi o nuovi libri da preparare o ristampare, libri d’ altri, classici, amici, editori, tutto ciò che riguardava l’ odiosissima e amatissima realtà, e infine ci addentravamo nell’ impossibile. Qualche volta gli raccontavo: cosa che entrambi amavamo; gli narrai, ad esempio, Inno omerico ad Ermes, che non conosceva e gli piacque moltissimo. Ogni giorno c’ era la telefonata, dal ristorante o da casa, alle tredici e trenta. Non sapeva che io, alle tredici e trenta, cominciavo a tagliare la mia bistecca al sangue. Quando ero arrivato quasi a metà della bistecca, suonava il telefono: era la voce affettuosa o lieta o dubbiosa o drammatica di Gadda, che voleva mettermi al corrente. La telefonata durava almeno venti minuti; e intanto la mia bistecca intristiva, intirizziva, diventava gelida e indesiderabile. Se glielo avessi detto, Gadda si sarebbe ucciso per la vergogna e la disperazione. Non so cosa mi attraesse soprattutto in lui: forse l’ intensità e la ricchezza di ogni momento della sua vita. Il momento non era, per lui, come ad esempio per Fitzgerald, qualcosa di lieve ed effimero, futile e doloroso, ma sempre volatile, che passa, scompare, e noi rimpiangiamo senza nemmeno conoscerlo. Il momento era, per Gadda, un «nodo», un «groviglio», un «gliuommero» come diceva il dottor Francesco Ingravallo nel Pasticciaccio: spesso, folto, denso, quasi impenetrabile dove convergevano il passato (di Gadda e del mondo), il presente, il futuro, la realtà, il sogno, il tragico, il comico, la colpa, il rimorso, l’ immaginazione, il gioco, la follia e «tutte le male bestie», come nella pentola delle streghe del Macbeth. Niente poteva essere dimenticato o cancellato. Credo che da questa intensità del momento nascesse la grandezza tragica di Gadda, che portava in ogni cosa che faceva e diceva, e che talvolta conferiva ai suoi interlocutori. Era un eroe plutarchesco: un eroe fallito, o sconfitto, «dimenticato dallo sguardo di Dio». Come tutti gli eroi sconfitti e dimenticati, Gadda abitava lontano dalla realtà: questo caos di carte sporche, gusci d’ uovo, sciocchezze, turpitudini, trivialità, delitti, scene comiche, gioielli, suoni, voci, blaterii, e Leggi nascoste, che alla fine formavano una sola polpa coloratissima. Malgrado la ripugnanza, egli sentiva un’ attrazione profondissima verso le cose. Ne aveva una conoscenza ugualmente profonda: sia per le superfici, sia per le Leggi della materia, «premeditate» o «suggerite» da Dio. Pochi scrittori ebbero un occhio così infallibile nel cogliere la nota essenziale di una persona o di una scena. Nell’ inverno 1956-1957, Gadda mi pregò di portarlo, in automobile, al grande mercato di piazza Vittorio, presso la stazione Termini. Nel decimo capitolo del Pasticciaccio, un poliziotto, Pompeo detto il Biondone, vi arresta un ladruncolo, Ascanio Lanciani, il quale ha appena intonato il meraviglioso «inno della porchetta». Gadda voleva controllare la scena, che credo avesse già composto. Il Biondone arriva alle dieci di un 23 marzo: noi, tanti anni dopo, giungemmo alle undici di una chiara mattina invernale. Gadda scese dall’ automobile e si incamminò: io accanto a lui. Mentre ci inoltravamo tra le bancarelle, il suo sguardo mutò: diventò attentissimo, intenso, inquisitivo, come se non potesse perdere nemmeno un colore della «gran fiera magnara»; e insieme grave, perché la realtà, quale essa sia, ha bisogno del nostro rispetto. Sembrava in trance. Ripeté l’ itinerario del Biondone nel romanzo: i pesci, le trippe, i capretti, i peperoni secchi, gli abbacchi, le montagnole di bianco-azzurri finocchi: risentì l’ odore delle caldarroste: guardò le piramidi di arance, le noci di Sorrento, le susine di Provenza, le susine di California: i polli vivi, le galline stipate nelle gabbie; e infine arrivò al reame delle porchette dalla pelle d’ oro, «adagiate sul tagliere prone o più raramente supine, o addormitesi di lato», che esibivano «i lor visceri di rosmarino e di timo…, o una foglia di menta amara». L’ inquisizione di Gadda non fu lunga: circa mezz’ ora. Quando uscì dal trance, si distese, accennò un sorriso, e mi pregò di riportarlo a casa. Tra gli scrittori italiani del suo tempo, Gadda ammirava soltanto Eugenio Montale. Un giorno mi disse che avrebbe voluto scrivere un commento alle Notizie dall’ Amiata, una delle poesie più belle delle Occasioni: conservava qualche appunto, ma non si sentiva la forza per svilupparlo, aggiunse tristemente. Tutto, in Montale, gli piaceva: la conversazione lo incantava: adorava la piccola musica elegantissima e un poco fumistica della sua ironia; e gli pareva, al confronto, di essere goffo e grave. Ma tra le sue categorie mentali, ne esisteva una importantissima: quella di fico secco; tutto ciò che è arido, ingeneroso, limitato. Il sovrano incontrastato del regno dei fichi secchi era Piero Gadda Conti, suo cugino: che egli invidiava (per la ricchezza ereditata), disprezzava come scrittore (sebbene gli inviasse lettere entusiastiche); ed amava (un poco). Purtroppo anche Montale aveva una piccola parte di fico secco. «Se non ce l’ avesse, sarebbe un uomo grandissimo». A via Blumenstihl 19, parlavamo soprattutto di classici. Non leggeva volentieri né i macaronici né gli scapigliati (che detestava); e nemmeno uno scrittore grandissimo come Rabelais. I suoi veri padri erano i romanzieri e i filosofi: Cervantes, Manzoni, Balzac, Dostoevskij, Proust, Saint-Simon, Platone, Spinoza, Leibniz – e Freud. Verso Flaubert era piuttosto freddo. Ma amava moltissimo, in Madame Bovary, la scena dei Comices agricoles, che Flaubert diceva di aver concepito come una sinfonia. Quel giorno, a Yonville-l’ Abbaye, c’ erano la garde nationale, i pompieri, le croci d’ oro che splendevano al sole, le scure redingotes, le bandiere tricolori, i muggiti dei tori, i maiali addormentati, il discorso del Consigliere di Prefettura che esaltava il Sovrano e il Progresso, mentre Rodolphe corteggiava e seduceva Emma Bovary «dalle lunghe ciglia curve». In questa scena Gadda scorgeva un simbolo della propria arte: con le antitesi, le contraddizioni, e l’ intreccio sinfonico dei toni. Mi disse che avrebbe voluto tradurla, sottolineandone il grottesco e il «groviglio». Ma l’ idea, come tante, rimase un progetto. * * * Quando Gadda cominciò il Pasticciaccio, pensava a Guerra e Pace. «Se avessi fiato (cioè gioventù e denaro) vorrei viaggiare tutt’ Italia», scrisse a Gianfranco Contini, «impadronirmi dei dialetti: fare un pasticcione con interlocutori nei vari dialetti: un settetto di voci con veneto, bolognese, bresciano, romano, fiorentino, napoletano ecc. ecc. come in certi numeri di “variété”. Un Guerra e Pace col principe Bolkonskij che parla milanese, Nicolenka bolognese, donne fiorentine ecc. ecc.». Forse non sapeva che anche Guerra e Pace era un settetto: anzi più che un settetto: con la lingua settecentesca del vecchio Bolkonskij, l’ intreccio di francese e russo in Andrej Bolkonskij – e poi la lingua dei Rostov, la lingua di Natasha, la lingua di Pierre, quella di Platon Karataev, quella di Kutuzov e dello zar Alessandro e di Napoleone. Gadda iniziò il Pasticciaccio alla fine del 1945: durante il 1946 e l’ inizio del 1947 compose circa duecentoventi pagine, pubblicate via via su Letteratura; con quell’ impeto, quella furia, quella velocità, quell’ «urgenza esplosiva», che conosceva nei momenti di ispirazione. Continuò più lentamente fino al 1949: salvo tre pagine, ignoriamo cosa abbia scritto. Certo, non la fine: sebbene nell’ aprile 1948 Gadda assicurasse Contini che «anche la coda serpentesca del coccodrillone» si era snodata; quella coda era soltanto una fine provvisoria, che avrebbe trasformato o rifiutato. Nel luglio 1953, Livio Garzanti propose a Gadda di ultimare il Pasticciaccio, offrendogli un anticipo allora vistoso. Garzanti aveva trentadue anni: era intelligente, nervoso, ombroso, bizzarro: possedeva una cultura non comune tra gli editori italiani. Era un vero editore. Come tutti i veri editori, desiderava pubblicare libri bellissimi, e imporli, con lo slancio, la seduzione, il danaro, a un pubblico vasto. Più tardi venne travolto dal suo spirito di distruzione e di autodistruzione. Ma allora era protetto da Attilio Bertolucci, che gli dava eccellenti consigli; e l’ avvolgeva con l’ immensa dolcezza e mitezza, nella quale la sua nevrosi, o quasi follia, si era trasformata. Garzanti aveva compreso ciò che quasi nessuno, allora, capiva: il Pasticciaccio era un grande romanzo. Non comprese che lo stile di Gadda era composto a strati successivi, come una torta ligure o siciliana; e che egli non raccontava in linea retta, ma fingendo di perdere il filo e soffermandosi su particolari in apparenza insignificanti, come una pagnottella imbottita o un pitale pieno di gioielli, che riflettevano le Leggi della natura. Nemmeno i critici letterari lo avevano capito. Ma Garzanti fu l’ unico editore che sia mai riuscito nell’ impossibile impresa di costringere Gadda a scrivere un libro: lo fece con un’ intelligenza, uno slancio e un fervore che, oggi, hanno qualcosa di unico. Quando rilesse il romanzo, scrisse: «Mi pare che nessuno di noi si sia reso conto sino in fondo dell’ importanza del Suo libro: forse ci vorranno anni. Io mi sento commosso e quasi impacciato ad esserne l’ editore»: le lettere che egli ricevette da Gadda sono state appena pubblicate nel quarto numero dei Quaderni dell’ Ingegnere curate benissimo da Giorgio Pinotto, (Einaudi pagg. 370, euro 35). Ho assistito alla pubblicazione di molti libri. Non ho mai conosciuto un entusiasmo come quello che c’ era allora in casa editrice, a via della Spiga, a Milano. Il direttore di produzione, Francesco Ravajoli, mi disse: «è bello come I promessi sposi». Non aveva torto. Con grande energia, tra il 1955 e il giugno 1957, Gadda compose il primo volume del Pasticciaccio. Doveva scrivere molte pagine nuove (non sappiamo quante): riscrivere i capitoli pubblicati su Letteratura: tagliare un capitolo, lasciando appigli per il secondo volume: correggere il dialetto romanesco, e avviare il secondo volume. Come al solito, ci furono rinvii e ritardi, dovuti, diceva Gadda, al «terreno vulcanico» sul quale viviamo; ma il rinvio è sempre stato un aspetto necessario nella scrittura di Gadda («sono il morante, il remorante, colui che tarda a far tutto, a leggere, a scrivere, ad andare, a venire»). Il Pasticciaccio in volume è più bello, credo molto più bello, della sua prima apparizione in Letteratura: lo stile non conosce mai le fredde isterie di Eros e Priapo. Come un famoso linguista dell’ Ottocento aveva detto dei Promessi Sposi, venne scritto con «l’ infinita potenza di una mano che non pare avere nervi». Il 9 giugno 1957, l’ ultimo capitolo, con le correzioni definitive, fu spedito a Garzanti: il 25 o 26 luglio il romanzo apparve in libreria: in piena estate, in una stagione poco propizia alle vendite. Oggi quasi nessuno immagina la profonda ostilità con cui il Pasticciaccio venne accolto. Mario Missiroli, un genio filosofico-politico, che allora dirigeva Il Corriere della Sera, impedì ad Emilio Cecchi, il critico italiano più influente, di dedicare al Pasticciaccio un elzeviro, cioè due colonne di stampa. Era un libro «irrilevante e senza respiro»; e quindi un «taglio basso», cioè due cartelle, bastavano e avanzavano; ma Cecchi pubblicò in ottobre un lungo e bellissimo articolo sull’ Illustrazione italiana. Giulio Debenedetti, direttore della Stampa, ebbe la stessa idea di Missiroli: ma poi si ricredette. Il premio Marzotto venne negato. Il Pasticciaccio non piaceva a Calvino (che poi cambiò parere), né a Moravia, né a Elsa Morante – e nemmeno a Pasolini, che gli preferiva L’ Adalgisa. Il successo letterario del Pasticciaccio venne deciso da una dozzina di giovani scrittori e critici: alcuni stavano a Roma, altri a Milano, uno a Voghera, uno era nato a Vicenza: avevano trent’ anni o meno di trent’ anni; e, tranne uno, erano sconosciutissimi. Non posso dire che comprendessero il Pasticciaccio, che forse è un libro incomprensibile: ma, per loro, incarnava la letteratura e il sogno della letteratura. Gadda era contento: forse fu l’ ultimo momento di quasi felicità della sua vita. Comprese quanto fosse ancora grande la sua energia creativa: a sessantatré anni, quando i romanzieri (tranne Cervantes) non scrivono più romanzi, o grandi romanzi. Le recensioni negative lo lasciarono quasi indifferente. L’ amore e fervore giovanili, che sentiva attorno a sé, gli piacevano. E certo lo lusingò il fatto che, quando il Premio Marzotto gli venne negato, Emilio Cecchi e Raffaele Mattioli inventarono apposta per lui il Premio degli editori. Almeno ad alcuni, sembrava che negare un premio al Pasticciaccio fosse un’ onta che andava pubblicamente cancellata: una simile riparazione, in Italia, non era mai accaduta. Come Proust, Gadda pensava che un’ opera letteraria, specialmente moderna, sia «una cattedrale incompiuta»: manca sempre la conclusione, un passaggio, una spiegazione, un’ illuminazione, una vetrata, un capitello, «una cappellina, con la sua statuetta in un angolo». Ma, alla fine del 1957, con le sue forze consce e inconsce, Gadda voleva concludere il libro; e si irritò con Garzanti, perché aveva fatto apporre la parola Fine nell’ ultima pagina del primo volume. Del secondo volume, mi parlò decine di volte: non della trama, perché difendeva i suoi segreti romanzeschi. Mi disse che avrebbe dovuto ritoccare in più punti il primo volume: che avrebbe utilizzato in flash-back (parola che detestava) una quarantina di pagine della versione di Letteratura: e che aveva già scritto una trentina di pagine nuove. Come ripeté a Giulio Cattaneo, il secondo volume avrebbe compreso centoventi-centoquaranta pagine. Poi si stancò: diventò indifferente e quasi ostile verso il proprio libro; come Ruskin, pensava che «nessun grande cessa di lavorare finché non raggiunge il punto di fallimento». Lui lo aveva raggiunto. Le Leggi, premeditate o suggerite da Dio, rimasero nascoste. Questi sono i misteri del Pasticciaccio: forse non li scopriremo mai, nemmeno se l’ introvabile manoscritto venisse alla luce. * * * Poi vennero gli anni terribili. Come Gadda scrisse a Livio Garzanti nel gennaio 1968, «tenga presente che la fine sarà lenta e dunque spiacevole». La fine fu lenta. Venne riassalito dall’ angoscia di essere stato espulso nel mondo, gettato nel mondo, e «dimenticato dallo sguardo di Dio». Viveva «con la psiche esterna alla pelle»: così che tutte le sensazioni e gli avvenimenti diventavano atroci – una piccola disattenzione, una parola non compresa, un gesto avventato, una dimenticanza, un nome sbagliato risvegliavano in lui un vortice tragico. Agitazione e depressione si alternavano nella sua anima. Era posseduto dallo strazio dei ricordi, dal peso dei propri pensieri, dal peso di tutti i ricordi e pensieri della terra. Sentiva la colpa: la colpa di essere figlio di Adamo: la colpa di essere nato, di avere avuto un’ infanzia infelice, padre e madre che non «gli ridevano»: quella di avere combattuto nella prima guerra mondiale sopravvivendo al fratello, e in primo luogo, la colpa di scrivere. Allora lo aggredivano i rimorsi. «Come giustificarmi davanti al rimorso?», diceva. «Le orribili pene dell’ animo sempre taciute e chiuse – mi scrisse – hanno ora acquistato un carattere ossessivo, e si chiamano disperazione, specie nelle ore del “rilasciamento”, cioè del sonno-dormiveglia-sonno-incubo». La «fedele Giuseppina» lo costringeva davanti alla televisione, per vedere il festival di Sanremo. A volte, piangeva, e si vergognava di piangere. Conobbe l’ umiliazione di vedersi diminuito: inferiore nella mente all’ immagine di sé stesso che aveva inseguito. Soffriva per la propria decadenza, con lampi di angoscia e di collera negli occhi. Un giorno, gli parlai di Eraclito. Rispose «Ma chi è Eraclito? Forse Eraclito sono io, l’ ombra di Eraclito sopravvissuta a me stesso». Grazie ai Promessi Sposi, la morte fu più lieta. Aveva sempre provato un «sentimento di venerazione privata» verso la persona di Manzoni. Da ragazzo, tra i nove e i sedici anni, aveva letto dieci volte I promessi sposi, abbandonandosi alla lettura, mi scrisse, «con la semplice e profonda gioia di chi si disseta in montagna a una fonte di acqua chiara». Ora, giunto alla fine, voleva ripetere l’ esperienza di adolescente, e chiese a Ludovica Ripa di Meana, a Giancarlo Roscioni e a me di leggergli I promessi sposi. Ci alternammo al capezzale. Mi ricordo che qualche giorno prima (o il giorno prima) della morte, gli lessi il meraviglioso ottavo capitolo: Don Abbondio che non conosce Carneade: Agnese che distoglie e allontana Perpetua chiedendole se era stata rifiutata, come dicevano, da Beppe Suolavecchia e da Anselmo Lunghigna: Tonio e il fratello che, a tarda sera, pagano il loro debito a Don Abbondio; la sorpresa di Renzo e Lucia che vogliono farsi sposare, la sorpresa dei Bravi nella casa di Agnese e Lucia; il suono delle campane a martello: quel casuale e gioioso formicolio della vita, che Manzoni e Gadda amavano tanto. Disteso sul letto, con la testa rialzata dai cuscini, Gadda rideva sussultando nel suo grande corpo moribondo – il riso, che tante volte lo aveva salvato. Allora pensai che la letteratura è davvero una cosa bellissima, se conserva la vita come la vita non riesce a conservarsi, e se fa ridere di gioia in punto di morte. Infine giunse la gloria: assoluta, incontaminata, quasi incontestata: la gloria dimostrata dal lavoro scrupoloso degli interpreti, come nei Quaderni dell’ Ingegnere, diretti da Dante Isella con tanta attenzione e precisione. Qualche volta rimpiango il fervore cieco dei giovani scrittori del 1957, quando Gadda era la letteratura vivente: questi giovani sono, adesso, diventati vecchi o vecchissimi, o sono morti. Forse il vero segno della gloria di Gadda è un altro. Dopo la sua morte, mi ha raccontato Ludovica Ripa di Meana, la «fedele» ed «eroica» Giuseppina, che aveva servito venerato e vessato il padrone per tanti anni, tornò a casa, a Ferentino. Aveva ereditato i diritti d’ autore, i mobili, i vestiti: non i libri e i manoscritti. Ora, finalmente, Giuseppina dormiva nel letto di Gadda: era una specie di consacrazione della sua vita. Tutte le domeniche apriva l’ armadio, dove stavano i vestiti e le grandi scarpe di Gadda. Prendeva le scarpe, e le lucidava con infinita cura, sino a renderle brillanti, come se Gadda, chissà dove, camminasse per le strade della vita o della sopra-vita. Questo – ne sono certo – è il tocco definitivo.
PIETRO CITATI25 agosto 2006 50 sez. CULTURA